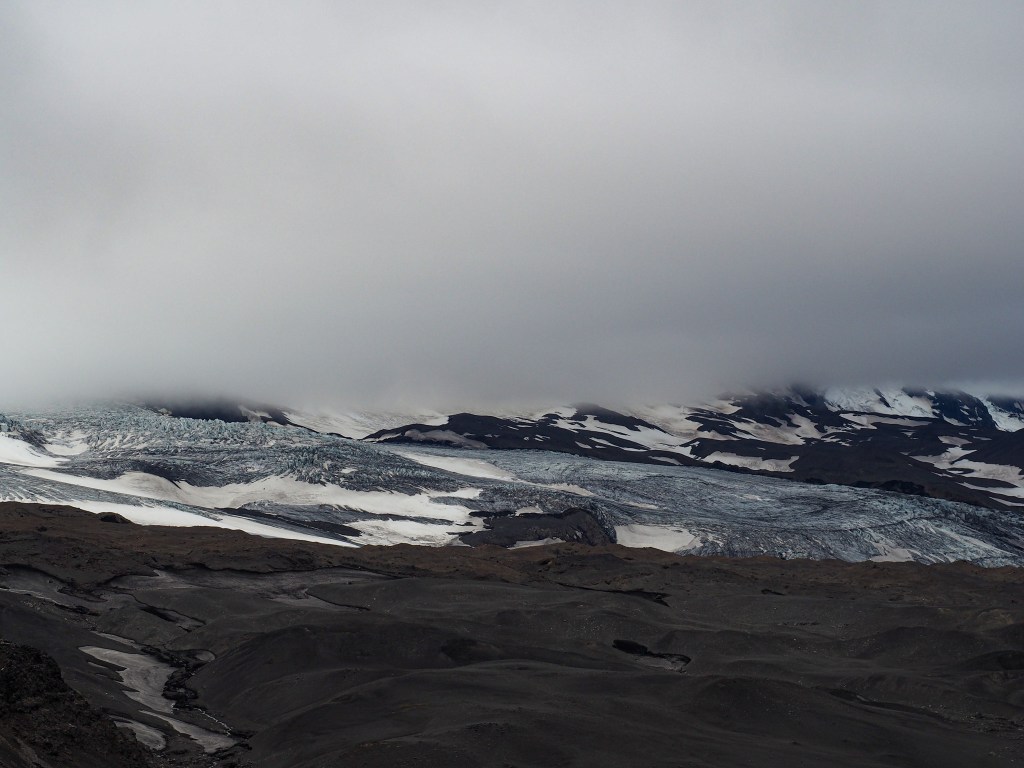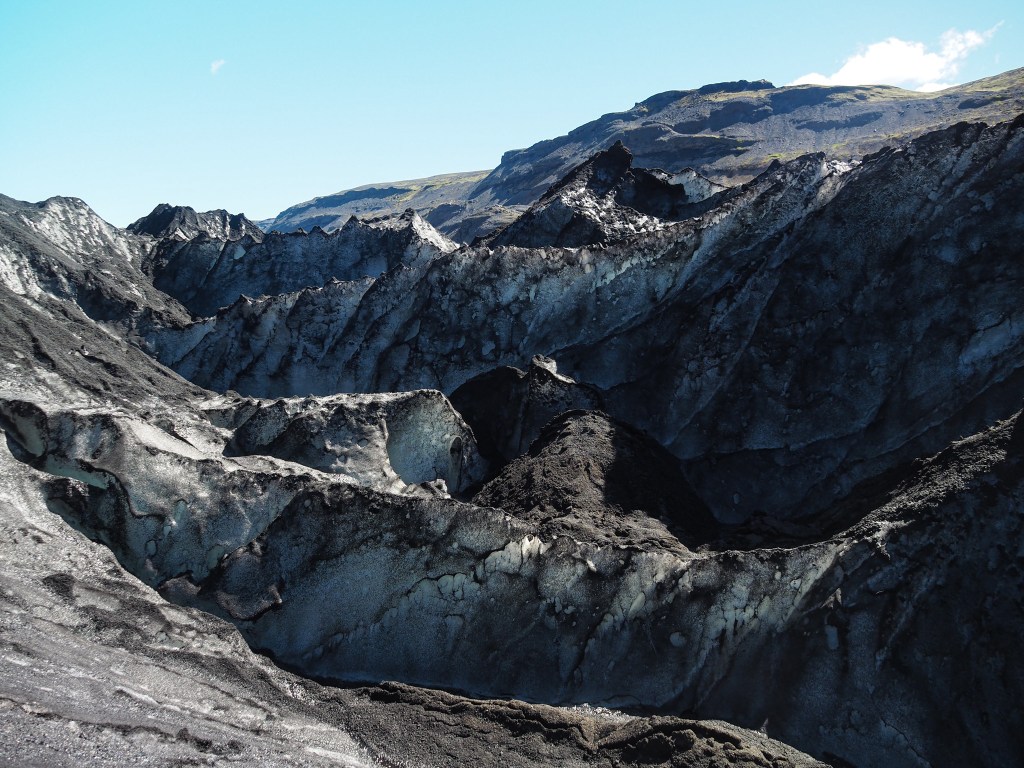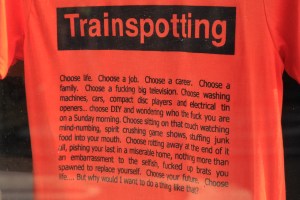Il 20 gennaio del 2015 ho pubblicato nel blog la mia wishlist, l’elenco delle cose che voglio fare prima di diventare troppo decrepita e rincoglionita, e nel tempo l’ho pure rimpinguata. I sogni non finiscono mai, almeno i miei, anche se arrivati a una certa, sarebbe ora di impegnarsi di più a spuntare righe invece che ad aggiungerne.

Quando dunque si è iniziato a parlare delle vacanze di quest’anno, mi sono vista tipo Zio Paperone quando fiuta un affare, solo che i miei occhi, normalmente castani, erano diventati improvvisamente blu. Dei profondissimi buchi blu, come il numero 35 della lista, che è lì da quando ho iniziato ad andare seriamente sott’acqua nel 1998. Ventisei anni sono un bel po’, ma io sono tenace e so aspettare, e alla fine arrivo (quasi) sempre a quello che voglio. Se dipende essenzialmente da me, ça va sans dire.
Guatemala e Belize o Belize e Guatemala? L’ordine non è poi così importante, l’importante è che che in Belize c’è la seconda barriera corallina più grande del mondo, e in mezzo a quella barriera c’è il Great Blue Hole, esplorato per la prima volta da Jacques Cousteau nel ’71. Se si va in Belize, non si può non andare lì. Non posso non andare lì.
Non facevo più immersioni da anni, causa eventi collaterali della mia vita personale più varie ed eventuali che hanno riordinato le priorità, e necessitavo di un refresh. La subacquea è una roba delicata, uno di quegli sport dove non puoi permetterti di star lì a pensare cosa fare, le azioni devono essere naturali ed automatiche, sopra e sotto. Montare l’attrezzatura, controllare la tua bombola e quella del compagno, scendere, compensare, respirare lentamente, mantenere un buon assetto, controllare i parametri, tener d’occhio il compagno, fare attenzione a non sforare la curva e monitorare l’aria, risalire a velocità controllata, sosta di sicurezza, superficie.
Di tutto questo, la sola capacità che temevo di aver perso era l’assetto, che è la caratteristica fondamentale che distingue un buon subacqueo da uno scarso. Il saper restare alla profondità stabilita in maniera composta e con minime variazioni, controllate dal respiro o attraverso GAV per lo stretto indispensabile. La bombola poi è una, più aria si usa per il GAV, meno ce n’è da respirare.
Dunque mi sono messa alla ricerca di un centro SSI a Milano per organizzare la mia rentrée sott’acqua, e da nerd quale sono, ho controllato review, referenze e tutto quello che ho potuto prima di contattare la struttura e andare di persona. Mi ci son trovata subito bene, a pelle, dalla prima volta che sono entrata. Non è un posto per fighetti, l’owner ha all’attivo migliaia di immersioni (una leggenda della subacquea, ma questo l’ho scoperto solo dopo) e conosce il mio vecchio istruttore. Abbiamo parlato un po’ della mia esperienza, di quello che avrei voluto fare e mi ha fatto una proposta che andava oltre i miei programmi. Ci ho pensato giusto un attimo e poi “SI”. Ero entrata per uno Scuba Skills Update di poche ore e un tuffo in mare, e invece un paio di mesi dopo avevo in tasca un brevetto Nitrox EAN40. Nel mezzo sono passate una serie di lezioni sull’utilizzo delle miscele arricchite di ossigeno, appunti, formule, calcoli e proporzioni che mi hanno risvegliato la voglia di imparare.
La teoria l’ho frequentata insieme a due tipi alle prime armi che non potevano essere più diversi: un simpatico brianzolo che in vista della pensione ha deciso di investire tempo e soldi in acque tropicali, attento alle spiegazioni e consapevole della sua (in)esperienza, e un insopportabile sbarbatello che non stava zitto un attimo – datemi il brevetto che io so già tutto e siamo qui a perder tempo. Una di quelle menti eccelse formatesi alla scuola di FacciaLibro, che se mi fosse mai capitato come compagno di immersione in mare, gli avrei chiuso la bombola a 30mt. La pratica l’ho fatta separatamente 1:1 con l’istruttore, e quando in piscina sono tornata a montare l’attrezzatura, i gesti sono arrivati naturali, come se l’avessi riposta la settimana prima.
Poi l’uscita in mare, nell’AMP di Portofino. La registrazione al diving, i pesi – Quanti chili? Quattro dovrebbero bastare, la cintura ho la mia -, la cassa in cui stipare pinne e maschera, monta il GAV e l’octopus sulla bombola prima di caricarla in barca. La mia attrezzatura – ven’tanni sul groppone ma perfettamente conservata e revisionata – si confonde tra le altre, quello che invece mi ha fatto sentire anacronistica è l’unico pezzo nuovo di zecca, una muta umida da 5mm quando tutti gli altri si apprestavano ad infilarsi dentro le stagne. Anche io ho il brevetto per la stagna, e lì per lì ho pensato di aver clamorosamente sbagliato a valutare la temperatura dell’acqua, ma siamo in agosto e si prevedono almeno venti gradi, e io la stagna la usavo da ottobre in poi. Mah.
Primo tuffo alla secca Carega che è da sola un trattato di biologia del Mediterraneo, secondo al Cristo degli Abissi. Nel briefing la guida ci spiega il profilo dell’immersione e cosa andremo a vedere. Per la mia rentrée farò coppia con uno dei divemaster, giusto per star tranquilli. Passo del gigante per entrare in acqua, ci siamo tutti, si scende.
Per cinquanta minuti sarà tutto blu, riesco a compensare senza alcun dolore alle orecchie, scendiamo ai 33 verso la parete di gorgonie rosse e c’è anche tanto pesce: cernie, salpe, dentici, castagnole e un branco di barracuda stanziali. Riesco a mantenere un assetto decoroso ed uscire con un quarto di bombola d’avanzo alla prima immersione, un po’ di più alla seconda.
Obiettivo raggiunto, posso partire tranquilla.
(Comunque la temperatura era perfetta, e riguardo all muta rimango della mia opinione: se ti butti in mare in modo da non sentirlo addosso neanche quando l’acqua è a venti gradi, o hai sbagliato sport oppure fai parte della categoria che si spalma protezioni ipertenologiche ogni tre per due per poi restare tutto il tempo sotto l’ombrellone, attento a non sporcarsi neanche di sabbia)
Il resto alla puntata numero 2.